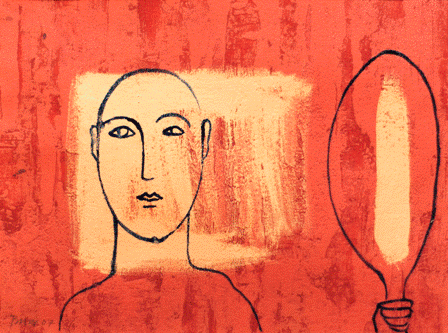Giovanni Buzi: Evangeline
Avevano detto di lei che era una strega. L’avevano detto fin da quando era stata una bambina, troppo bella per quel piccolo villaggio ai margini della foresta, sepolto nell’ombra perenne di monti alti e minacciosi. Il nome che le avevano dato, Evangeline, non le si addiceva, perché faceva pensare ad una creatura mite e sottomessa, mentre lei era più libera del vento dell’inverno, e altrettanto imprevedibile; un giorno gelido, giungendo da nord, e il giorno successivo caldo, piovendo dalla cresta dei monti. Poi era cresciuta ed era diventata una fanciulla alta e sottile, con gli occhi color dell’erba di primavera, e i capelli rossi, come le foglie degli aceri in autunno. Quando se ne andava per la foresta, molti si auguravano che non tornasse, perché nessuno con un po’ di buon senso osava percorrere quei sentieri dimenticati. Conducevano, si diceva, in un’altra terra e in un altro mondo, dove non c’era posto per gli umani timorati di Dio. Nessuno tornava dai quei luoghi.
*
È stato facile tornare; è bastato volerlo.
Credevo non fosse possibile attraversare terra e pietre.
Invece...
Il bosco profuma, ancora.
Anzi, forse ancor di più.
Crepitìo di foglie morte ad ogni passo. Odori di muschi e di resine. Tutt’intorno, invisibile, intenso, il profumo delle viole che si spande nell’aria, come volesse impregnare di sé ogni angolo del bosco, e non sparire.
Mai.
Riconosco questi profumi.
Riconosco tutto.
Solo che, nei miei ricordi, tutto qua intorno era immerso nel verde e nella luce, come in un fantastico acquario. Sempre, fra questi alberi mi sono sentita come fossi in fondo a un lago tappezzato di smeraldi.
Ora, è come avessero spento d’un sol soffio il sole.
Le acque del lago si sono spente e con esse, uno ad uno, ogni smeraldo. Eppure, anche in queste penombre tra il grigio piombo, il blu e il viola, ho l’impressione di riconoscere ogni albero, ogni foglia. Le foglie, di sicuro, non sono più le stesse. Quelle dei miei tempi, adesso sono polvere. Polvere frammista alla terra.
Com’ero io fino a poco tempo fa.
Qualche secondo fa.
Laggiù, tra un lento agitarsi d’ombre verde scuro e viola, vedo il paese arroccato su un blocco di tufo, come aquila che attende un sol colpo di vento per distendere le ali e scomparire. Quante volte, da bambina, mi sono rifugiata qui, nel bosco. Sedevo a terra e, palmi sotto al mento, attendevo che quel blocco compatto di case, tetti, chiese, castello e torri spalancasse le ali e volasse via. Verso l’azzurro. Invece, ancora, quell’aquila di pietra resta a fissare l’infinito, senza staccarsi da terra. Anche nella mia assenza, non s’è decisa al decollo. E adesso, congelata com’è in questo mondo di penombre, ogni suo pur minimo gesto sembra impossibile. Lenti riflessi blu notte scorrono sulle sue pesanti ali, sul corpo massiccio. Gli artigli infissi a terra, quell’immenso uccello volta il capo dal becco ricurvo. Lo volta verso di me. Sento mancare un colpo al cuore, quando vedo un lampo turchese accendere, vive, due pupille.
Mi fermo.
Non riesco a staccare il mio sguardo da quello gelido, penetrante dell’aquila di pietra che, in un sol battito, si stacca da terra e, sempre fissandomi, si dirige, a lenti, potenti colpi d’ala verso di me.
Mi guardo intorno, sgomenta. Per un attimo le mie pupille vagano fra queste tenebre mobili, bluastre. Non riesco a ritrovare un ritmo di respiro regolare. Di colpo, un’idea mi rassicura: io non posso avere paura di ciò che è vivo, ora che sono morta. Alzo lo sguardo. Il cielo su di me è un solo, liquido agitarsi di marmo nero striato di lapislazzuli e ametiste. Un soffio freddo sulle guance, sui miei capelli del colore degli aceri in autunno e, immensa, vedo stagliarsi la sagoma scura di quel mostruoso rapace. Vengo assalita da un terrore senza nome. Per un attimo, desidero la perfetta calma della tomba. Quell’uccello spalanca le ali. Vedo fremere ogni piuma. D’improvviso, cade in picchiata su di me. Le sue pupille s’accendono d’un turchese sempre più brillante! Un solo istante e tutto scompare in quel vivo turchese.
Sono annegata negli occhi di quel rapace.*
Evangeline, dai quindici ai diciassette anni, età della sua morte, era stata l’amante del conte Alceste del Buono, proprietario del paese e del bosco circostante, per miglia. Il conte l’aveva vista un giorno passare per una delle strade polverose del villaggio. Lei, come gli sguardi avessero un peso, si voltò e incontrò le pupille turchesi del vecchio signore. Per Alceste del Buono fu come le avessero tolto, in un solo istante, mezzo secolo dalle spalle. Si sentì un adolescente. Dimenticò sua moglie, i suoi quattro figli e s’innamorò di nuovo, con una tale potenza come mai avrebbe creduto fosse ancora possibile. Come aveva potuto quella ragazza, quasi ancora una bambina, strappargli con uno sguardo il cuore? Pur non essendo uno stinco di santo, questa volta il conte Alceste del Buono, rese onore al nome del suo casato. Sinceramente, s’era innamorato di quella splendida ragazza dallo sguardo verde primavera, tinto d’un che d’ambiguo. Verde vivo dal retrogusto di muschi e sottobosco. Nei boschi, quella ragazza spesso spariva, come inghiottita dal palpito segreto delle fronde degli alberi. Quale forza si celava all’interno di quegli strani occhi? Perché bastava un suo solo sguardo per far impallidire ogni persona? Perché quella ragazza era stata dotata d’una bellezza che dava brividi freddi? Da chi? “Non certo da Nostro Signore, iniziarono a dire le paesane. Cristo, morto per noi sulla Croce, altro non vuole che la pace e la concordia”. Se non opera del Divino, la conturbante bellezza d’Evangeline (e mai nome fu dato a sproposito, si diceva ancora in paese) doveva essere opera del Diabolico. Non era stata quella bellezza a far perdere la testa a un padre di famiglia che, se non esemplare, fino a quel momento aveva almeno saputo tenere uniti moglie e figli. Come aveva saputo difendere e tenere saldamente in mano il feudo. Ora tutto poteva disfarsi come neve al sole. La sua sposa, la contessa Odoacra, nata da nobile stirpe, aveva riempito i bauli di sontuoi abiti, messo ogni gioiello in un capiente forziere e, accompagnata da gran parte della servitù, aveva abbandonato il castello in un mesto corteo di carrozze. I due figli maschi, di 24 e 26, anni avevano preso a contendersi le terre del feudo, totalmente abbandonate dal padre, in tutt’altre faccende affaccendato. Le due figlie femmine, di 34 e 35 anni, eterne zitelle, avevano iniziato a lanciarsi reciproci insulti perfino sulla soglia della cattedrale, tanto l’una sfogava la propria rabbia d’essere al limite del mostruoso contro la propria sorella-specchio. Il vecchio Alceste lasciava fare, anzi, neanche s’accorgeva di ciò che accadeva intorno a lui, rapito com’era dall’incomparabile bellezza e sensualità d’Evangeline, ogni giorno più bella e maestra nelle arti dell’amore. Fu fatto appello al vescovo Gualtiero Mareschi Intonso, che presto si convinse dell’indubbia presenza del Maligno in quella triste vicenda. Una sera di scoppi di lampi nel cielo livido, arrivò una delegazione della Santa Inquisizione. Niente poté il vecchio conte. Il processo fu breve. Messa a tortura, Evangeline cofessò; sì, era una strega, una seguace del Dio Caprone. Per questo andava così spesso, da sola, nei boschi. Per incontrarlo. Per fornicare con lui, il Maligno. Non c’erano altre persone presenti a quei riti. Era solo lei. Lei che attendeva il manifestarsi del Demonio. A volte, si presentava sotto le mentite spoglie d’un giovane viandante, a volte in quelle d’un mendicante, d’un cavaliere, d’un cervo, d’un cigno, d’un drago... Illimitata è la fantasia del Demonio. Meno d’una settimana e tutto fu concluso. Non ci fu bisogno di bruciare su un rogo Evangeline, morì in fase di tortura. Il suo corpo fu sepolto, in luogo segreto, sotto a un albero del bosco.
*
Sollevo le palpebre.
Freddo e buio, intorno a me.
Dov’è finito quel mostro gigantesco, quell’aquila che m’ha inghiottito nel turchese dei suoi occhi?
Dovevo tornare in vita per sentire questo terrore?
Se vita è.
So d’essere morta eppure, vedo, sento, riesco a pensare. Riesco ad avvertire veri brividi, come adesso. Brividi di paura? Il mio corpo è filo d’erba che freme prima della tempesta. Nessuna traccia di quel mostro alato. Solo quest’infinito strato d’ombre, gelide più della morte. Un acutissimo fischio mi lacera i timpani; il tempo di tappare con i palmi le orecchie e un lampo m’acceca. Un lampo turchese! Quel mostro alato risorge dall’infinito strato d’ombre. Con un colpo di becco lo squarcia e piomba di nuovo su di me! Ho gli occhi feriti da lame di luce, eppure non abbasso lo sguardo. D’improvviso so perché sono risorta, se risorgere è in questo caso il verbo da usare. So che devo compiere una missione; è questa certezza che mi dà la forza di non abbassare il capo, neanche di fronte a un’aquila gigantesca che può tagliarmi in due con una sola unghiata.
Il mio sguardo riesce a bloccare l’aquila.
Bloccarla in pieno volo.
Il cielo dilaga d’un accesso color rosso cinabro.
Al rallentatore, l’aquila richiude le immense ali, stira le zampe verso il basso. Gli artigli si muovono lenti, come volessero lacerare il cielo. Cielo che gradualmente vira all’arancio, il giallo, il rosa pallido. Millimetro dopo millimetro, come una leggera, irreale montagna l’aquila scende verso terra, lo sguardo vivo sempre fisso su di me. Il becco ricuro s’apre e compare la lama affilata della lingua rosso sangue. Lo sento, sta per lanciare un grido immane. Un urlo che mi farà esplodere la testa, come una pallottola un guscio d’uovo. Per interminabili secondi, attendo.
Quel becco resta aperto e silenzioso come uno squarcio nella pietra. Un lampo turchese accende le pupille di quel mostro, nel momento in cui di nuovo s’appollaia sullo sperone di tufo su cui riposava da millenni. Riconosco il paese arroccato, i tetti, le case, le strade, la chiesa, il castello. Sono là di fronte, a poche centinaia di metri. Verso di essi, riprendo a camminare. È l’alba. Un frusciar di fronde mi distrae. Un colpo di vento anima i miei lunghi capelli rossi. I miei passi sono leggeri, come fossi ancora immersa nell’acqua. Poco a poco, questa sensazione svanisce e resto, io morta, a respirare l’aria fresca che profuma di primavera. Le vesti di seta bianca s’agitano agli invisibili respiri della vita, come invisibile devo essere io; scivolo accanto a un contadino che va a piedi al lavoro e non mi degna neanche d’uno sguardo.
Se davvero sono invisibile, sarà ancora più agevole portare a termine la mia missione. Riconosco le strade del paese. Muli, asini, oche, galline starnazzanti. Quella vecchia sta ancora fuori di casa al sole, la morte deve averla dimenticata. Nugoli di bambini scalzi e sporchi, sciamanti come zanzare. Gli uomini sono al lavoro nei campi, resta alla finestra l’apparizione di qualche vecchio e gli sguardi fugaci delle donne. Tutto, a momenti, si fa mobile e acquoso, come nei ricordi d’un annegato. Passo accanto alla grande chiesa; il tempo d’intravedere scomparire un lembo di stoffa nera dietro una porta che si chiude. Laggiù, dove sempre sono state, vedo le mura che circondano il castello. Quel luogo che conosco così bene. Avanzo ancora e, senza un fremito, attraverso la spessa muraglia. Mi ritrovo nel grande giardino. Riconosco gli alberi, le statue di pietra, i getti d’acqua delle fontane, le sontuose poltrone di vimini, i sentieri, le immense voliere in fil di ferro bianco. All’interno, vedo svolazzare un gioco di riflessi; torna quella sensazione di ritrovarmi in fondo a un lago. A brandelli, la trama della realtà si sfilaccia e, attraverso smagliature, mostra altro. Di fronte alle grandi voliere, mi soffermo. Attraverso la fitta tessitura di rami e foglie in fil di ferro bianco, s’agitano, trasparenti nella trasparenza, sottili, liquide vibrazioni. Traiettorie d’invisibili voli, come invisibili sono i miei pensieri, come invisibile sono io. Un agitarsi nell’aria e le mie vesti di seta fremono. Qualcuno ha aperto il portale del castello che dà sul giardino. Eppure, nessuno appare sulla soglia. È in quel preciso momento, che, per una frazione di secondo, il mio cuore vacilla.
Posso farlo? Ho il diritto di farlo?...
Un accenno di sorriso m’increspa le labbra mentre penso che i morti hanno, ormai, tutti i diritti. Lenta, riprendo a camminare. Avvicinandomi a quel portone aperto, ad ogni passo, avverto la luce del sole affievolirsi. Al momento di poggiare il piede sulla soglia, è notte fonda. Su di me, un formicolìo di stelle. Entro. Ancora quella sensazione di trovarmi in fondo a un lago. Ma questa volta sembra d’una profondità abissale. Ogni oggetto, ogni pietra, ogni cosa riluce d’una pallida fluorescenza bluastra. Anche i suoni si fanno liquidi e fluorescenti. Sì, riesco a vedere i suoni. Riesco a vedere l’eco dei miei passi sulla pietra. Sono onde vibranti, fasci d’infinitesimali corde che pulsano d’un tenue viola turchese. Le vedo aprirsi, amplificarsi in mobili flussi che si rincorrono in traiettorie definite dal cozzare contro mura, mobili e oggetti. Sento il suono d’un clavicembalo provenire dal salone. Forse, come accadeva spesso dopo cena, Clarice, la figlia minore del conte, sta suonando. Attraverso la massiccia porta chiusa e mi ritrovo nel salone. La prima cosa che vedo è il turbinìo calmo delle note accendersi di viola blu, azzurro e tocchi di bianco puro, brillante. Tutt’in fondo, intravedo un vibrare opaco di figura umana seduta al clavicembalo divenuto un solo blocco d’argento vivo. Poco distanti, seduti su seggiole dagli alti schienali, gli altri componenti della famiglia del Buono: Rosalinda, la maggiore, Oddone e Pancrazio, i due figli, la moglie del conte, la nobile Odoacra dei marchesi Palinsesti e infine lui, Alceste, il mio ex amante. Di loro non riesco a vedere che lo scheletro contenuto nell’involucro lattiginoso dei corpi. Gli scheletri vibrano d’una filigrana lucente e fragile, di fiocco di neve visto al microscopio; un solo colpo d’aria sembra avere il potere di disperdere ogni molecola delle ossa in pulviscolo errante. Continuo ad avanzare, investita dai flussi luminosi di quella musica visiva. Mi hanno torurato fino a farmi confessare che sì ero una strega, una fedele seguace del Demonio. Mi hanno ucciso. Mi hanno sepolto. Ma non sono riusciti a farmi scomparire. Ora sono qui per un motivo ben preciso. I miei occhi verdi brillano, i miei lunghi capelli rossi hanno il colore e la consistenza della fiamma. Le vesti di seta bianca s’agitano come gocce di latte cadute in un bicchier d’acqua. Mi hanno fatto confessare d’essere una strega, ma ciò che ignoravano, ciò che ignorano, è quanto io lo sia. Quanta è la mia potenza. Al centro del salone mi fermo. Do un ultimo sguardo circolare a ogni componente della famiglia del Buono. Prendo un gran respiro, per pochi istanti trattengo l’aria, poi in un sol soffio la getto fuori e, indifferente, resto a contemplare quegli scheletri che si scheggiano, si frantumano e infine si perdono in pulviscolo iridescente.
Pubblicato nella raccolta "Schegge di Mondi Incantati", Racconti fantastici dal Trofeo RILL e dintorni, 2007
contatti con questo sito: giovannibuzi@yahoo.it