Giovanni Buzi: L'Anfora
“Guarda laggiù!”, tra i gorgoglii, la voce di Mauro arrivò come da un altro pianeta. Stefano si girò e vide il fascio di luce proiettato dalla fronte dell’amico perdersi in una voragine blu. Un colpo di pinne, un movimento delle braccia, come di volo, e anche lui orientò il capo verso il basso. Il buio fu spazzato da una sciabolata azzurra e nelle profondità del mare si creò una “v” luminosa.
“Andiamo a vedere”, tornò metallica e lontana la voce di Mauro.
La “v” luminosa si scompose in una danza lenta dei fari. Anche Stefano ormai la vedeva: sembrava proprio la pancia di un’anfora la superficie arrotondata che occhieggiava fra i coralli morti. Senza una ragione apparente, per un raggio d’un paio di chilometri i coralli erano ridotti ad un intrigo di vermi biancastri, pietrificati. Ciuffi filamentosi d’alghe grigio verde e una sorta di muffa color ruggine invadevano come lebbra le rocce. In quella porzione di mare erano rari pesci e crostacei, ma abbondava una specie particolare di stelle marine: tozze, color grigio bluastro, coperte d’asperità e aculei piramidali di circa due centimetri di lunghezza. Immobili, spettrali, sembravano esemplari in avanscoperta d’un popolo rifugiato da millenni negli abissi. In quella zona si trovavano una decina di relitti, da navi d’epoca etrusco-romana fino ad un sommergibile dell’ultima guerra mondiale, la cui carcassa sventrata appariva all’improvviso ritagliata nel blu. Vera miniera per gli archeologi, la zona era tenuta sotto severo controllo e vietata a chiunque non fosse provvisto di regolare permesso. Mauro e Stefano facevano parte della sezione d’Archeologia Subacquea dell’Università Parthenope, alla Facoltà di Scienze Nautiche di Napoli. Sì, era proprio un’anfora. Un’anfora d’epoca romana, intatta, ma delle più banali. Corpo svelto, due manici e base affusolata, destinata al trasporto d’olio, vino ed altre mercanzie. Nei secoli, di quel genere ne erano state fabbricate a milioni. Le fu dato un numero di repertorio e fu spedita al laboratorio per analizzare il contenuto. Era pesante; di solito l’interno veniva colonizzato da molluschi, col tempo si formavano depositi calcarei che misti al materiale d’origine, sabbia, conchiglie e rocce creavano una massa dura come cemento. Mauro e Stefano, vale a dire il dottor Ferri, titolare della cattedra d’Archeologia Subacquea e il dottor Moretti, suo assistente, dimenticarono presto l’anfora e col nucleo di ricerca ripresero le investigazioni nel settore “Coralli Morti”, a pochi chilometri a largo d’Amalfi. Arrivarono i risultati dal laboratorio: impossibile scalfire la massa cementizia all’interno dell’anfora. Il responsabile del laboratorio, dottor Ernesto Castelli, aggiungeva due righe di suo pugno chiedendo se fosse urgente un’analisi approfondita. Ad una settimana scarsa dall’inizio delle sacrosante ferie - il laboratorio chiudeva per tutto agosto - non aveva voglia d’iniziare complesse analisi con il probabile risultato di trovare tracce di vino, semi di grano o noccioli d’oliva. Il dottor Ferri prese il telefono,
“Allora, dottor Castelli, è proprio tanto dura quest’anfora? Sarà il solito “blocco intestinale”. In gergo, l’espressione definiva il contenuto poco appetitoso di un’anfora, non capitava tutti i giorni di ritrovare i gioielli di Cleopatra.
In effetti, era dura. La massa che s’intravedeva aveva l’aspetto di cemento con inglobate pagliuzze d’acciaio.
“Che roba può essere?”, chiese il dottor Ferri.
Il capo del laboratorio picchiettò con una sorta di bisturi e disse,
“Nessuna idea. Tu cosa pensi?”
“Mai visto niente di simile in un’anfora, né altrove”.
“Ieri ho eseguito l’esame di radioattività. Il materiale, qualunque esso sia, è perfettamente stabile. Per gli altri esami è meglio aspettare settembre”.
Il dottor Ferri continuava ad osservare con la microlampada,
“Sabbia, ciottoli, di sicuro resti di coralli, ma c’è dell’altro. Facciamo una radiografia?”
Sistemarono l’oggetto su una barella e lo trasportarono in sala-radio. Da dietro la parete trasparente, il capo del laboratorio spinse un bottone. Lo schermo del computer s’accese d’azzurro. All’interno dell’alone appena più chiaro dell’anfora apparve, di vivo turchese, una figura dal disegno d’una precisione demoniaca. Su un trono squadrato d’una ventina di centimetri d’altezza sedeva un mostruoso ibrido. Testa di falco, braccia e gambe d’uomo, sul torace tre paia di mammelle sovrapposte alla verticale, tra le gambe un pungiglione eretto, ripiegate dietro alle spalle due ali squamose. Ma ciò che più impressionava era lo sguardo: due occhi tondi di rapace notturno color arancio vivo. Pulsanti. I due dottori erano rimasti a bocca aperta. Dopo un lungo silenzio, il dottor Castelli disse,
“Che cavolo è?”
“Gesùmmaria!, fu la laconica risposta dell’illustre collega”.
***
Museo Archeologico di Napoli. Sezione “civiltà preromane”. Sala 0/1: 5 metri su 5, pareti, suolo e soffitto rivestiti di velluto nero, al centro, in una custodia di cristallo, illuminato da un solo faretto troneggia “A X”, Amuleto X, così era stato chiamato lo strano oggetto. Nonostante le numerose analisi, non era stato possibile identificare la materia. Alla vista sembrava una sorta d’alabastro, al tatto risultava freddo come cristallo di rocca e più duro del granito. Si tentò d’intaccare la base con acidi, inutilmente. Si provò col trapano a punta di diamante, stesso risultato. La materia non trovava nessuna corrispondenza con ogni altra conosciuta. Poiché non fu registrata nessuna emissione di radiazioni, si decise d’esporre l’oggetto, sia pur all’interno d’una vetrina antiproiettile e perfettamente sigillata. Il ritrovamento fece scalpore. I media se ne appropriarono, il pubblico accorse numeroso. Se la materia non fu identificata, una ragione esisteva: s’era cercato nel campo della materia inorganica. “A X” non apparteneva al regno minerale, bensì a quello animale. Era un essere vivente, sui generis, sia bene inteso. Dopo sei mesi, la statuetta custodiva intatti i suoi segreti. Non furono d’ausilio pareri d’illustri uomini di scienza né d’archeologi. Poco a poco, l’interesse diminuì e l’Amuleto X restò sempre più isolato fra quattro mura di velluto nero. La notte del 15 gennaio 2010, la città di Napoli fu investita da un’eccezionale ondata di freddo. La temperatura era scesa di vari gradi al di sotto dello zero, nel cielo sgombro di nuvole splendeva una luna piena appena sfumata di blu. L’interno del museo era immerso nelle penombre. Nella sala 0/1 non c’era alcuna finestra, il solo accesso sbarrato da una porta blindata. Incastonato nel metallo della porta, un rettangolo di spesso cristallo attraverso il quale, ad ogni ronda, i sorveglianti controllavano l’amuleto. Per aprire la porta blindata c’era bisogno di due chiavi, una custodita dal capo dei sorveglianti, l’altra in una cassaforte la cui combinazione era nota al solo direttore del museo. Impossibile entrare. Fosse accaduto, un reticolo a raggi infrarossi avrebbe fatto scattare immediatamente l’allarme. Fu per questo che il sorvegliante, la notte del 15 gennaio, si stropicciò per ben due volte gli occhi prima d’avere la certezza che l’Amuleto X era scomparso.
Ma non dovette cercare molto. Ingigantito, si trovava alle sue spalle. Pasquale Diotallevi avvertì un soffio sul collo. Si girò e non ebbe il tempo di lanciare un grido.
Alto più di due metri, apertura alare d’almeno il doppio, in un palpitare lattiginoso l’ibrido lo fissava con i suoi occhi di fuoco. In un batter d’ali gli fu addosso, lo gettò a terra, con le sue zampe mostruose l’immobilizzò, come una lama affilata gl’infilzò il suo pungiglione nella pancia che lento prese a cercare e risucchiare le ossa del poveretto.
Quando accorsero gli altri guardiani non trovarono che un corpo molle completamente privo di scheletro.
L’Amuleto X era, impassibile, all’interno della vetrina.(Pubblicato nella raccolta "Il mio mare", IIa edizione, a cura di Gianfabio Scaramucci e Patrizia Bassani, Editrice La Mandragora, Imola, 2006)
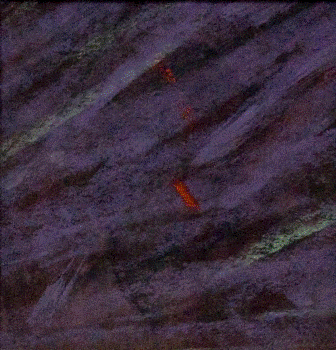
Giovanni Buzi, Frammento n° 790 (2002)
- Home
- Romanzi
- Racconti
- Racconti su siti Web
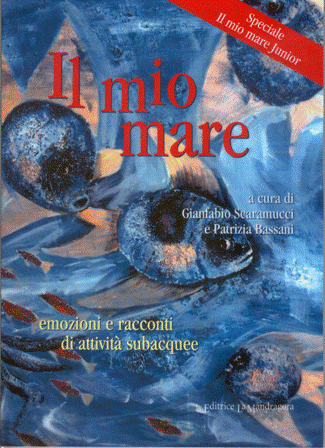
"L'Anfora" è stato pubblicato nella raccolta "Il Mio Mare", IIa edizione, a cura di Gianfabio Scaramucci e Patrizia Bassani, Ed. La Mandragora